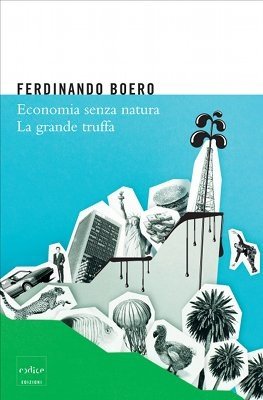
Il testo che segue è estratto dalla Prefazione al libro di Ferdinando Boero “Economia senza natura” (Codice edizioni, uscita prevista per maggio 2012) che qui pubblichiamo per gentile concessione dell’editore.
Nel 1859 è stata pubblicata l’Origine delle specie, il libro più importante che sia mai stato scritto. Il libro che ha cambiato radicalmente il nostro modo di vedere il mondo.
La parola ecologia all’epoca non esisteva ancora, l’avrebbe coniata poco tempo dopo Ernst Haeckel. Non esisteva la parola, ma esisteva il concetto. E Darwin, quando parlava della disciplina che oggi chiamiamo ecologia, usava l’espressione economia della natura.
L’economia si riferisce alle nostre attività, a come produciamo e consumiamo acquisendo crediti e contraendo debiti. L’economia della natura ha a che fare con attività simili, perché anche in natura ci sono produttori e consumatori, e i sistemi naturali funzionano in modo simile a quelli economici. O sarà il contrario? Chi c’era prima? Noi o il resto della natura? La risposta è ovvia: il resto della natura. Quindi queste regole, quelle che normano produzione e consumo, sono regole naturali che nel corso del tempo abbiamo adattato al nostro vivere da uomini.
Prima abbiamo guardato dentro di noi (e abbiamo concepito l’economia) poi abbiamo guardato fuori (sviluppando l’economia della natura). Poi abbiamo cambiato parola, e l’economia della natura è diventata ecologia. Forse è stato un male. Se il termine fosse rimasto lo stesso (economia) forse sarebbe rimasto sempre evidente lo stretto legame dell’economia dell’uomo con quella della natura. Ma non si può tornare indietro. Le cose cambiano continuamente. Evolvono. Nulla rimane per sempre uguale. La natura cambia in continuazione, e così anche l’economia.
Ora il titolo di questo libro dovrebbe essere trasparente e chiaro. L’ecologia studia fenomeni naturali, l’economia fenomeni artificiali. Ma l’artificiale può permettersi di coniare leggi e regole differenti da quelle naturali?
Conoscere l’economia della natura (e quindi l’ecologia) potrebbe essere utile per capire l’economia? Io penso di sì. Tuttavia non è previsto l’insegnamento dell’ecologia (l’economia della natura) nei corsi di laurea in economia (dell’uomo), e gli economisti pensano che l’ecologia sia qualcosa di alieno alle loro necessità formative.
Questo libro argomenta un’unica tesi: l’uomo fa parte della natura e le regole che inventa sono alla fine soggette alle regole della natura. Tutto qui. Non sembra così ovvio? Eppure tutti i guai in cui ci siamo cacciati, e quelli in cui continuiamo a cacciarci, derivano dal non aver capito questo semplicissimo concetto.
Basta poco per convincere persino un economista che l’economia della natura prevale sull’economia dell’uomo. Qualche mese fa ero sul Leonardo Express, per andare da Fiumicino a Roma, e ho iniziato una discussione “da treno” con un amico incontrato lì per caso. Con lui c’era un signore molto serio che, per un po’, è stato a sentire le mie elucubrazioni sull’ambiente e sull’uomo. Ma a un certo punto il mare di castronerie che (secondo lui) stavo dicendo ha superato il limite ed è sbottato: «Tutto questo va contro le leggi dell’economia, e non si può scherzare su queste cose! Si devono valutare i costi e i benefici, e su questo si decide! Il resto sono chiacchiere!». Io, ovviamente, chiedevo che nei costi fossero inclusi anche i costi ambientali, che gli economisti furbamente esternalizzano (una bella parola per dire che non li considerano: tanto li pagano gli altri) nelle loro analisi. In quel momento però non volevo rispondere con sottili ragionamenti, e mi è venuta in mente un’obiezione che ha annichilito il mio interlocutore: se le leggi dell’economia e quelle della natura entrano in conflitto, quali prevarranno? Fine della storia. Non possiamo essere così arroganti da pensare che siano quelle dell’economia a prevalere. Se infrangiamo le leggi della natura a favore di quelle dell’economia, la natura ce la farà pagare cara, carissima. Anche in termini economici.
(…)
Economisti, ingegneri e tanti altri non conoscono le leggi della natura, perché non fanno parte dei loro programmi formativi. Se le conoscessero non ci avrebbero messo nei pasticci in cui ci troviamo ora. Intendiamoci, non sto dicendo di essere io a conoscerle. Ne conosco qualcuna, so che ci sono, che sono importanti, ma molte cose ancora ci sono ignote. Ci siamo concentrati troppo su noi stessi, e abbiamo perso il contatto con la realtà.
Non sono uno storico dell’economia, e neppure un economista. Sono uno zoologo e un ecologo-evoluzionista, un naturalista; e forse è un vantaggio. Cerco di capire regole naturali alle quali, volenti o nolenti, dobbiamo sottostare. Se qualche economista leggerà questo libro, sono convinto che lo troverà ingenuo nelle parti di sua competenza, e troverà di sicuro delle incongruenze, almeno rispetto a quanto ha studiato. Tuttavia, considerata la serie infinita di problemi che la sua categoria professionale ci sta facendo patire, visto che abbiamo seguito alla lettera i consigli dei suoi colleghi, forse potrebbe fargli sorgere qualche dubbio. Voglia perdonare i miei errori e cerchi di concentrarsi sulle parti che non sono di sua competenza (e sulle quali invece un pochino sono ferrato) e forse, partendo da nuovi dubbi, potrà trovare nuove strade. In modo da far sì che la nostra economia sia comunque un corollario di quella della natura, così che l’economia comprenda l’ecologia (che la capisca) e vi si faccia comprendere: nel senso che l’economia è tale solo se diventa “della natura”.


